Gli scandali del mondo finanziario sembrano voler riportare le lancette del tempo alla Grande Recessione, quando – a cavallo tra il 2007 e il 2008 – la bolla dei mutui subprime travolse l’economia americana e negli anni successi – con la crisi del debito sovrano europeo (2010-2011) – l’Europa. Oggi a far salire la febbre sono i fondi pensione inglesi, la speculazione sulle Crypto e sul settore tecnologico (dove l’indice Nasdaq sta scivolando verso il basso), ma soprattutto la difficoltà nel frenare l’inflazione in un contesto geopolitico scosso dalla guerra in Ucraina e lo spettro dell’atomica. Di fronte a questo avvenire tumultuoso si è scelto di attribuire il Nobel dell’Economia (con tutti i distinguo del caso) a Bernanke, Diamond e Dybvig, invitando così gli analisti e il mercato a una riflessione sul proprio agire e sulle possibili conseguenze che le loro azioni stanno avendo sul presente. Dalla stretta delle banche centrali alle speculazioni sui mercati a spot, tutto lascia intendere che la lezione che avremmo dovuto apprendere dalle recenti crisi non è servita a granché, anzi, forse ha solo dato l’illusione che tutto sia concesso.
La Grande Recessione e la lezione che nessuno vuole imparare.
La bolla da cui scaturì la crisi dei mutui subprime fu un amalgama di avidità, di omertà e di opportunismo che lasciò un segno indelebile nella fiducia dei risparmiatori. Ed oggi è importante ripartire proprio da quel contesto per capire la mitizzazione dell’incoscienza, divenuta all’epoca driver principale dell’agire degli operatori del mercato, e le contromosse messe in campo da Bernanke, Diamond e Dybvig.
All’inizio degli anni 2000, superata la bolla del Dotcom, il mondo si apprestava a cogliere i primi frutti della globalizzazione, ovvero, un minor costo d’importazione delle merci (prodotte perlopiù in Paesi in via di sviluppo) dovuto a minori costi di produzione, e una maggiore efficienza, il tutto accompagnato poi da tassi d’interesse bassi.

In quegli anni la Fed, infatti, scelse di mantenere bassi i tassi d’interesse per due ragioni ufficiali, la prima per riemergere più velocemente dalla bolla del Dotcom e la seconda per dare una risposta reattiva di fronte agli attacchi terroristici dell’11 settembre. Si potrebbe aggiungere che la politica monetaria espansiva fu anche dovuta all’apprezzamento che il dollaro stava subendo in quel periodo grazie agli acquisti di moneta da parte della Cina e che quindi la Fed dovesse abbassare i tassi per evitare che la valuta diventasse troppo forte. E tutto ciò, come riportato dalla Consob, non fece altro che stimolare la cessione di denaro senza se e senza ma per investirlo in forme d’investimento con rendimenti maggiori: questo è il mercato. Mantenere parcheggiato il denaro in titoli di Stato e obbligazioni dalla bassa remunerazione non aveva senso; quindi, si iniziarono a cedere crediti a persone senza garanzie e in cerca di case, in un contesto – quello del mercato immobiliare americano – che all’epoca era in forte ascesa (la tipica bolla). L’aspetto interessante della Grande Recessione è che essa non sarebbe stata tale senza l’aiuto di qualche apprendista stregone che per mezzo degli strumenti di cartolarizzazione più avanzati (C.D.O – Collateralised Debt Obligations) e della compiacenza delle agenzie di Rating ha potuto gonfiato la bolla immobiliare a più non posso. La quantità di denaro in circolazione era ingente anche per via dell’utilizzo della leva finanziaria, resa possibile dalla cartolarizzazione immediata di prestiti che sarebbero dovuti rientrare in 10-30 anni, la quale ha permesso alle banche di esporsi per cifre ben superiori rispetto al proprio capitale, inducendo così molti a dubitare del concetto stesso di solvenza.
Gli istituti di credito permettono l’incontro di un particolare tipo di domanda e di offerta. Da una parte ci sono i risparmiatori che voglio mettere al riparo i propri averi (di cui però vogliono anche la disponibilità immediata alla bisogna) e dall’altra ci sono coloro che necessitano di ingenti somme (imprenditori e chiunque voglia fare investimenti sul lungo periodo di cui non ha i capitali – ad esempio per un mutuo). In mezzo ci sono gli istituti di credito che a fronte di un tornaconto (gli interessi) gestiscono la liquidità in modo tale che entrambe le parti abbiano ciò che desiderano.
Prima e durante la crisi dei mutui subprime le banche si affidavano all’interscambio bancario per gestire le garanzie sulle posizioni aperte dagli investitori e le necessità dei correntisti, mantenendo sempre a mente che ciò che conta è essere solventi (ovvero detenere in pancia più crediti rispetto ai debiti, pur non avendo necessariamente i soldi dei correntisti nella propria pancia). Riducendo all’osso il meccanismo, tutto si regge sulla fiducia che i correntisti non si incolonnino tutti insieme agli sportelli per ritirare i propri soldi (come invece avvenne nella Grande Depressione – Crisi del ’29) e che gli investimenti non siano un buco nell’acqua (come invece accadde durante la crisi dei mutui subprime). Il crollo delle cartolarizzazioni dei CDO e di altri strumenti sintetici privi di garanzia determinò, tra il 2007 e il 2008, la perdita di fiducia tra gli istituti di credito e l’arresto del prestito interbancario (come poi capitò di nuovo nel 2011 con la crisi del debito sovrano). In altre parole, le banche non si prestano denaro se temono l’insolvenza di chi glielo chiede, e fu proprio quello che capitò a Lehman & Brothers.
La banca d’investimento americana, passata alla storia come il simbolo della crisi dei mutui subprime, nell’agosto del 2008 dichiarava a bilancio 28 miliardi di dollari, ma il suo sistema di finanziamento era insostenibile. Come scisse Walter Galbiati su Repubblica, “Ciò che rendeva Lehman Brothers più inaffidabile delle altre erano i suoi investimenti immobiliari e il modo con cui si finanziava: 7,9 miliardi di “pagherò” non garantiti e, quasi 200 miliardi (197 miliardi) di pronti contro termine, i “Repo”, alla fine del primo trimestre 2008”. L’aspetto più interessante di queste operazioni era il fatto che le società di revisione contabile, tra cui Ernest & Young (tra le Big Four) non esplicitò mai la natura di tali transazioni e la pericolosità ad esse associata. Quando Lehman fallì, la Fed dovette intervenire con oltre 700 mld di dollari per evitare l’effetto contagio, dopo aver però scelto di far naufragare un istituto di credito ritenuto, sino ad allora, too big to fail. Sul perché della decisione della Fed vi furono più e più versioni, lo stesso Bernanke cambiò versione almeno due volte. Alla commissione d’inchiesta spiegò che riteneva cosa nota l’esposizione di Lehman e che quindi i risparmiatori di altri istituti si fossero già liberati dei titoli tossici, successivamente, invece, diede la responsabilità a cause di natura tecnico-legale. Ed è qui, sui perché che la crisi dei mutui subprime si riaggancia al presente.
Perché Bernanke, Diamond e Dybvig hanno vinto il premio Nobel per l’Economia
Diamond e Dybvig hanno di fatto reso evidente l’estensione del meccanismo tra domanda ed offerta di denaro al di là dei soli istituti di credito più citati (ovvero le banche), perché esiste lo shadow banking e i Repo; ed hanno imposto l’unica strategia razionale da attuare di fronte a una corsa agli sportelli: keep calm and whatever it takes. L’esatto opposto di quello che avvenne nel ’29 e di ciò che prescrisse a suo tempo Milton Friedman. Il problema dell’approccio di Diamond e Dybvig, però, come suggerito dal premio Nobel per l’Economa Paul Krugman – dalle colonne del New York Times – è che soccorre le banche privante con i soldi degli istituti di credito centrali può portare ad un abuso, il famoso azzardo morale. Tradotto, se so che andando a sbattere non mi farò nulla, perché non farlo? Ed è su questa domanda che si aprono i problemi che coinvolgono il presente.
Al di là della letteratura, infatti, resta la difficoltà nel controllare e gestire efficacemente i problemi del presente, come sta avvenendo adesso con l’inflazione e i fondi pensione inglesi: due casi che spiegano perché alcune politiche monetarie possano fungere non solo da cura, ma anche da potenziale minaccia alla salute stessa.
I tassi d’interesse bassi, ad esempio, sono efficaci nel far ripartire la domanda, ma possono nascondere diverse insidie. Una di esse, come riportato da John Plender sul Financial Times, è che mantenere i tassi bassi possa, da una parte, attenuare – com’è di fatto avvenuto prima della Grande Recessione – gli effetti di una delocalizzazione della produzione in Paesi più poveri e una conseguente riduzione della domanda interna e di investimenti nei Paesi più avanzati. Ma dall’altra possa facilitare l’accesso al credito spingendo il comparto degli investimenti azzardati, come riportato da Franco Bruni – vice direttore dell’Ispi – che ha scritto “il guaio di tassi troppo bassi e sovrabbondante liquidità è anche quello di indurre gli operatori a investimenti con produttività media bassa e spesso molto rischiosi: un uso inefficiente delle risorse, peggiorato dalla facilitazione degli indebitamenti dei governi che ora non sarà facile sostenere”. Ed effettivamente, dai grafici sull’inflazione nella zona euro, emerge come gli obiettivi di post-Volckeriana memoria non sia stati raggiunti (almeno il più delle volte – il famoso 2%), mentre sia aumentato l’utilizzo di strumenti finanziari opachi e pericolosi, soprattutto durante la pandemia.
Tale quadro è sì pericoloso, ma non disastroso e ciò che rende il presente tumultuoso sono alcuni meccanismi che si pensava aver compreso e invece paiono ancora avvolti dalla nebbia. Si prendano ad esempio le misure della Fed in fatto di interessi. Paul Krugman era tra i promotori del piano ultra-espansivo di Joe Biden, salvo poi ammettere di essersi sbagliato e come lui tanti altri economisti che hanno sottovalutato il cambio di stile di vita che la pandemia ha indotto di moltissime persone. Ed è sempre Krugman, in due differenti editoriali, ad ammettere dapprima che il piano di Powell sulla stretta monetaria è già andato oltre i suoi obiettivi, innescando di fatto una recessione che c’è, anche se affetta da una sorta di jet-leg. In altre parole, ci vuole del tempo per vedere gli effetti di una stretta monetaria e continuare ad accanirsi sui tassi affinché l’inflazioni cali, così da giustificare il lassismo adottato prima che essa si palesasse (in tempo di tassi troppo bassi), risulta controproducente. Sempre Krugman, sottolinea poi come i modelli e gli indicatori adottati sino ad oggi per misurare l’inflazione abbiano ormai fatto il loro tempo: “Basically, simple rules for assessing where inflation is right now are broken. We’re in judgment territory — and that leaves lots of room for argument.”
Sul tema inflazionistico gli animi degli economisti sono divisi. Come racconta Andrea di Stefano in un articolo apparso sul mensile Millennium, esiste un nutrito gruppo di esperti che ritiene che quella in corso sia un’inflazione da profitto, ovvero un modo che hanno escogitato alcune società per incrementare i guadagni senza un giustificato aumento di altri indicatori (come ad esempio i costi). Ed a tal proposito, economisti del calibro di Piketty e Stiglitz continuano a insistere affinché si introduca una minimum tax globale al 25% sulle grandi aziende. Altrimenti il rischio è che il colpo assestato dall’incremento dei tassi delle banche centrali e la ventura recessione colpisca sempre i soliti noti, in un mondo, quello d’oggi, dove la disuguaglianza continua imperversare e per questo il ritorno alla parentesi sulla finanza malata è d’obbligo.
Mercati e istituzioni continuano a calciare più in là lattina
Il tessuto degli istituti di credito non si è ancora del tutto ripreso dalla Grande Recessione (come dimostra il caso MPS) e la situazione in cui versano importanti banche (tra di esse Credit Swiss e Deutsche Bank). Non c’è chiarezza sull’efficacia degli strumenti messi in campo per fronteggiare l’inflazione, come illustrato da Krugman, e la politica monetaria molto bassa per un periodo tempo così lungo ha incentivato investimenti rischiosi contro cui è stato fatto troppo poco per impedire effetti contagio sul mercato. In uno scenario così congeniato il crollo del Nasdaq e i timori che il Metaverso e altre iniziative delle big tech facciano un buco nell’acqua c’è e ci dice che la situazione potrebbe franare velocemente.
Ed è qui che l’attribuzione del premio Nobel per l’Economia acquisisce un senso. Bernanke, Diamond e Dybvig avevano già illustrato i rischi a cui si andava incontro dopo le crisi degli anni ’80 e 2000, ma poco è stato fatto e l’azzardo morale non è stato efficacemente frenato da nuove regole, anzi, una politica monetaria espansiva ha forse favorito gli appetiti degli speculatori. Ed oggi si ripropone di nuovo il problema che tolse il sonno ai banchieri centrali durante la crisi dei mutui subprime e successivamente in quella del debito sovrano: salvare i risparmiatori sapendo che gli speculatori la faranno franca, oppure lasciare che una si manifesti una depressione di dimensioni epocali per ripartire (chissà come e quando)? Nel mezzo si insinua la proposta di Piketty e Stiglitz, che però giace ancora senza eco tra i grandi del mondo.
di Claudio Dolci e Roberto Biondini


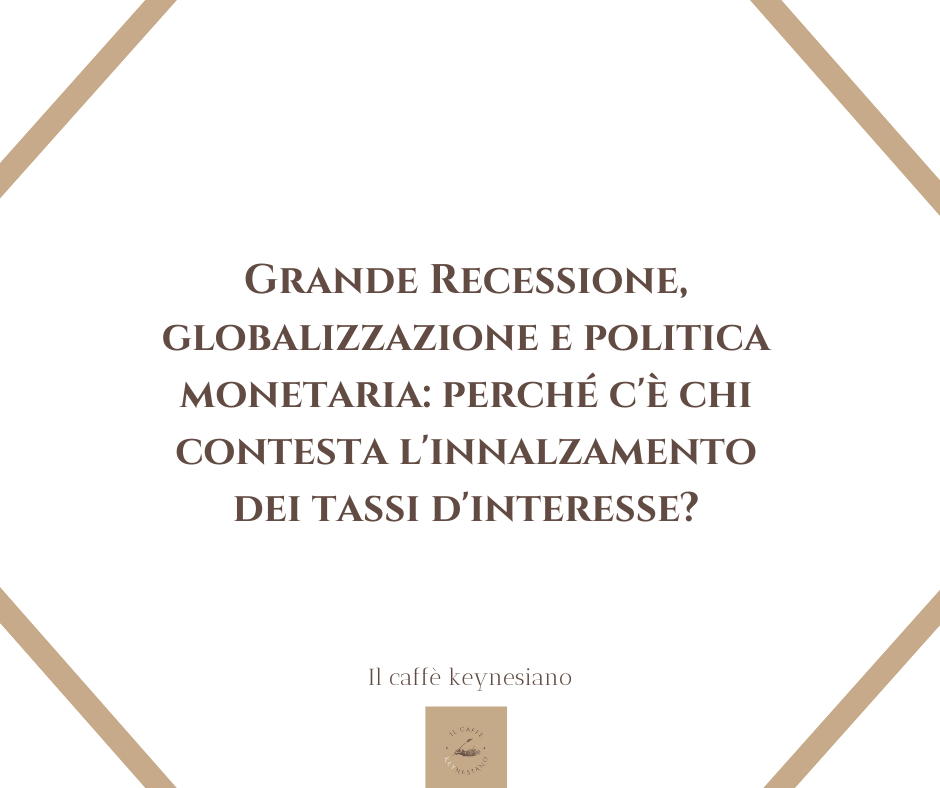
Approfondimenti
L’Europa dei veti al voto: l’analisi del Patto di Stabilità che verrà
Don’t cry for me Argentina
L’ingresso nell’euro e l’analisi di falsi miti: puntata II